THE GRANDMOTHER – David Lynch
Immergersi negli abissi inquieti della mente visionaria di Lynch è sempre opera complessa e delicata. Come delicato è il compito di valutare a ritroso nel tempo le primissime prove di quello che, nel corso degli anni, è stato declamato indiscutibilmente come il percorso artistico di un genio.
Di questo percorso The Grandmother rappresenta uno dei primissimi gradini, collocandosi tra lo sperimentale cortometraggio The Alphabet (1968), uno dei primi approcci al cinema del giovane pittore Lynch, e il lungometraggio d’esordio Eserehead (1977). E’ questo l’aspetto interessante di questa pellicola, ovvero la sua contestualizzazione che ci permette di fotografare la commistione delle visioni di un pittore astratto (o semi-figurativo) e cupo e i primi vagiti della sua anima cinematografica. In questi lavori c’è difatti un prevalere del Lynch pittore sul Lynch cineasta e, sebbene gli stilemi rimarranno mescolati nell’arco di tutta la sua carriera, è facilmente intuibile come in questi primi passi nel mondo del cinema il suo linguaggio visuale sia strettamente legato alla semantica della sua pittura.
Fotogrammi tetri, impressioni di un subconscio immoto che valicano i confini della cornice per cercare di raggiungere un grado di verità ancora maggiore proprio nel movimento, laddove per verità intendiamo quel passaggio tra idea e risultato che evita la tappa della più canonica “rappresentazione” per instillarsi direttamente nella percezione dello spettatore come grumo di sensazioni. Il primo Lynch soffre fortemente il limite della parola. The Alphabet, infatti, palesa senza veli le difficoltà di un individuo dotato di una natura non verbale. Le inquadrature sono ancora molto statiche e divengono pittura che inizia a stringere un legame col tempo filmico.
The Grandmother è il gradino successivo. L’animazione non è più protagonista, ma diviene accordo, traghetto, che ci accompagna in un viaggio che è lo stesso percorso del regista. Le parole, ansiogeno limite comunicativo, si sentono per la loro assenza, lasciando il campo al suono, apparentemente disconnesso, ma strettamente legato all’inconscio, alla natura,all’istinto e di una densità in grado di turbare e incuriosire e farsi trave portante di un anomala esperienza percettiva. Difatti Lynch, assieme all’inseparabile Alan Splet, occupò ben 62 giorni a registrare personalmente gli effetti sonori, per poi successivamente manipolarli e renderli un intenso groviglio comunicativo. Spesso i suoni che accompagnano i movimenti sembrano innaturali, come non ci fosse adesione con l’ambiente filmico, ma allo stesso tempo paiono come gli unici e i soli in grado di concordare col soggetto (ad esempio le lenzuola tirate all’indietro sono state sonorizzate con l’oscillazione di una mazza da golf riprodotta alla rovescia).
Quello che va via via costruendosi è un nuovo linguaggio, in cui anche le animazioni in stop-motion, stilizzate e spartane, concorrono ad alimentare una vivida atmosfera che dipinge senza raccontare, comunica senza dire, avvolge senza spiegare. Il film ha come protagonista un ragazzo al centro di una famiglia surreale. I genitori dispotici e aggressivi nascono dal terreno come delle piante, e divengono allegoria delle ansie del ragazzo. Mike si muove ansante attraverso i suoi disagi. Questi si concretizzano spesso in macchie d’urina sulle lenzuola, che irritano il padre al punto tale di strofinarglici sopra il viso mentre emette animaleschi suoni gutturali. Il ragazzo, vestito con smoking e papillon, trova in solaio un sacco di semi, riempie un letto di terra e decide di coltivare i semi innaffiandoli. Da questi crescerà un baccello dal quale deriverà la figura protettrice di cui tanto sente il bisogno, concretizzata nella figura di una nonna. L’anziana dimostra subito cura e affetto per il ragazzo, continuamente vessato e intimidito dai genitori. Quando la nonna starà male Mike chiederà aiuto a loro due i quali si limiteranno a deriderlo.
Non solo non è semplice leggere il senso di un film di David Lynch, ma forse è pure ontologicamente sbagliato, poiché nel momento stesso che si esaspera la ricerca di un codice interpretativo, si forza la natura stessa dell’opera. L’incarnato bianco, i toni scuri e le stanze nere richiamano visivamente i suoi dipinti più tetri; così come i temi come la famiglia, la casa, la natura che mutano l’apparente idillio in minaccia, erano già rintracciabili negli stessi quadri. Non si tratta di ricercare un rapporto di stretta contiguità tra l’infanzia dell’autore e la sua visione artistica, che lui stesso racconta felicissima, bensì di captare l’ossessione del percepire sempre una visuale perversa, ignota e pulsionale celata nella normalità e nel quotidiano. Il continuo cambio di angolazione della macchina da presa è chiaro prodromo di un idea del cinema che verterà sempre sulla ricerca di stralci, punti di vista, occhiate e che nasce proprio dall’esigenza intima di introdurre il movimento nella sua pittura.
The Grandtmother è esattamente questo: ovvero la fotografia di queste pulsioni, di questi turbamenti rintracciabili nel familiare, manifestata nel momento in cui l’autore sperimenta il passaggio tra le due forme espressive. Esperienza che porterà Lynch ad essere uno dei pochi artisti in cui questi confini non verranno mai separati, dove la pittura sarà sempre anche cinema, il cinema sarà sempre pittura e il mondo un opera della propria mente, delirio di forme e sensazioni. “Quando vedi un mondo bellissimo, basta che guardi un po’ più da vicino ed è tutto un agitarsi di formiche rosse” (D.Lynch)
Regia: David Lynch
Cast: Richard White, Dorothy McGinnis, Virginia Maitland, Robert Chadwick
USA, 1970











 THEM – W.H. Chizmar (review & interview)
THEM – W.H. Chizmar (review & interview) THE SISTERS OF THE MOON Trilogy – Samantha Chambers
THE SISTERS OF THE MOON Trilogy – Samantha Chambers STEPHEN KING NOT JUST HORROR – Hans-Ake Lilja
STEPHEN KING NOT JUST HORROR – Hans-Ake Lilja SACKHEAD:The Definitive Retrospective on FRIDAY THE 13th PART 2 – Ron Henning
SACKHEAD:The Definitive Retrospective on FRIDAY THE 13th PART 2 – Ron Henning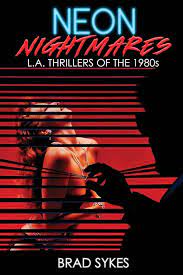 NEON NIGHTMARES: L.A. Thrillers Of The 1980′s – Brad Sykes
NEON NIGHTMARES: L.A. Thrillers Of The 1980′s – Brad Sykes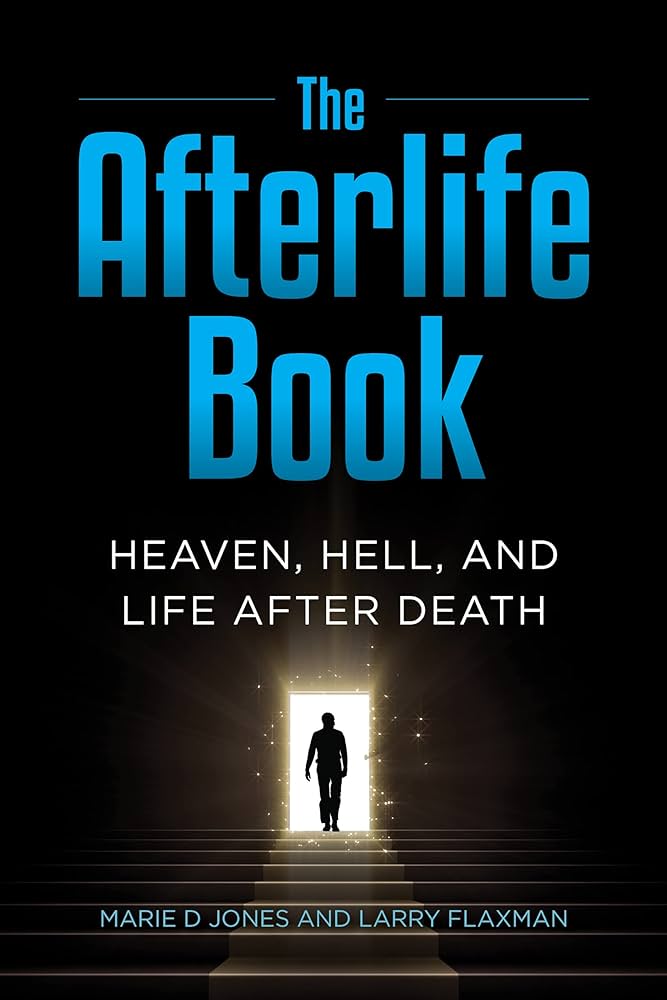 THE AFTERLIFE BOOK: Heaven, Hell, And Life After Death – Marie D. Jones & Larry Flaxman
THE AFTERLIFE BOOK: Heaven, Hell, And Life After Death – Marie D. Jones & Larry Flaxman POPULATION PURGE – Brian Johnson
POPULATION PURGE – Brian Johnson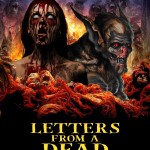 LETTERS FROM A DEAD WORLD – David Tocher (review & interview)
LETTERS FROM A DEAD WORLD – David Tocher (review & interview) A MYSTERY OF MYSTERIES: The Death and Life of Edgar Allan Poe – Mark Dawidziak
A MYSTERY OF MYSTERIES: The Death and Life of Edgar Allan Poe – Mark Dawidziak MR. PURPLE – review and interview with W.H. Chizmar
MR. PURPLE – review and interview with W.H. Chizmar